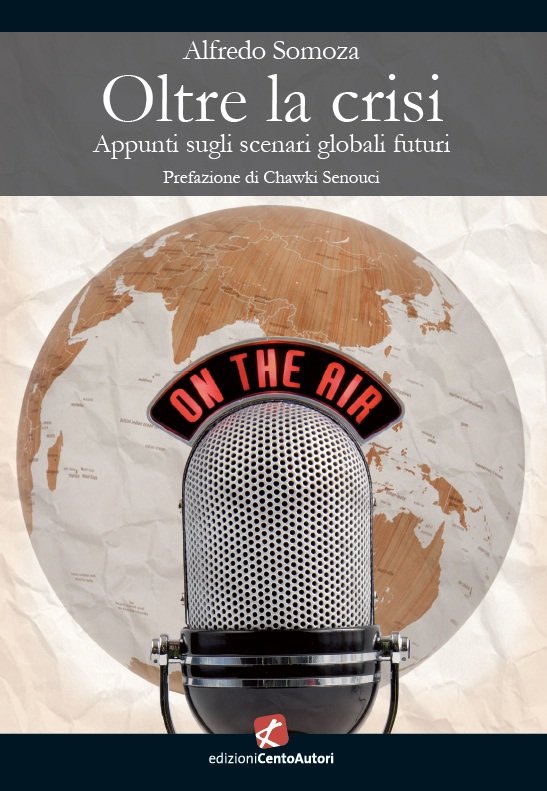L’Africa, se parliamo di telefonia mobile, è ormai il continente più collegato. La Banca Africana di Sviluppo ha calcolato che ci sono 650 milioni di utilizzatori di telefoni cellulari su un miliardo di abitanti del continente. Un rapporto telefoni per abitanti superiore a quelli dell’Europa e degli Stati Uniti. Questa è quindi la prima generazione di africani che ha accesso a un prodotto considerato di alta tecnologia: il possesso di un telefonino è spesso più frequente che l’accesso all’acqua potabile o all’elettricità.
Per gli africani, il telefono portatile è allo stesso tempo l’unico collegamento con il mondo, il portafoglio e la buca delle lettere. Questo perché nel Continente Nero, più che sui giochi o sulla musica, i gestori di telefonia puntano a offrire innanzitutto servizi utili, come la gestione dei conti bancari, le informazioni utili agli agricoltori, gli scambi commerciali. Questa rivoluzione è stata possibile grazie all’offerta di telefoni essenziali ma resistenti prodotti in Cina. Telefonini da 20 dollari USA, poco più di 16 euro, resi ulteriormente accessibili da agevolazioni fiscali che hanno abbattuto i prezzi ai consumatori.
Giovani e giovanissimi compongono il più grande gruppo di fruitori di telefonia cellulare: in Sud Africa si registra un picco di possesso del 72% nella fascia 15-24 anni. Le compagnie telefoniche che operano in Africa macinano bilanci miliardari composti da centinaia di milioni di consumatori poveri o poverissimi, nonostante abbiano dovuto fare i conti con il dilagare di modalità di comunicazione low cost tra i loro clienti. Come, per esempio, l’uso degli squilli senza rispondere, tecnica inventata in Africa per trasmettere notizie senza spendere soldi: una specie di codice Morse digitale. Per venire incontro a questa enorme fetta di consumatori è stato ideato il servizio “call me” che include un certo numero di sms giornalieri gratuiti.
Ma la rivoluzione dei cellulari in Africa sta aprendo la strada anche all’innovazione tecnologica autoctona. Vérone Mankou, un imprenditore ventiseienne della Repubblica del Congo, già nel 2006 ha sviluppato una linea di smartphone e tablet touch-screen adattati ai bisogni del mercato locale. Il suo smartphone Elikia (“speranza” in lingua lingala), che usa il sistema Android e viene costruito in Cina, è a tutti gli effetti il primo contributo tecnologico africano al mondo globalizzato. Quando Google ha rifiutato le carte di credito emesse in Congo per l’acquisto di applicazioni, Mankou ha lanciato una propria linea di apps “sviluppate da africani per l’Africa” e di carte di credito prepagate per l’acquisto online.
Il marchio VMK dell’imprenditore congolese per ora tiene testa a giganti della telefonia come BlackBerry, Samsung e Nokia. L’inedita sinergia tra Africa e Cina si sposta ora anche sul piano della ricerca e commercializzazione di tecnologie espressamente concepite per il mercato locale e per il potere d’acquisto dei consumatori africani. Con questo piccolissimo primo passo, l’Africa spezza dunque il ruolo secolare di acquirente netto di esportazioni a basso costo (e tecnologicamente superate) al quale la storia l’aveva relegata.
La Cina, che come molte altre potenze ha bisogno dell’Africa per rifornirsi di materie prime minerarie ed energetiche, sta interpretando le aspirazioni e le potenzialità creative di un miliardo di persone ancora ai margini dei mercati mondiali. È una scommessa che a lungo termine non può che pagare. Ed è interessante notare che solo chi è stato per secoli emarginato, come i cinesi, è riuscito a cogliere le potenzialità di un “mondo” formato anche dai continenti dimenticati.
Alfredo Somoza per Esteri (Popolare Network)