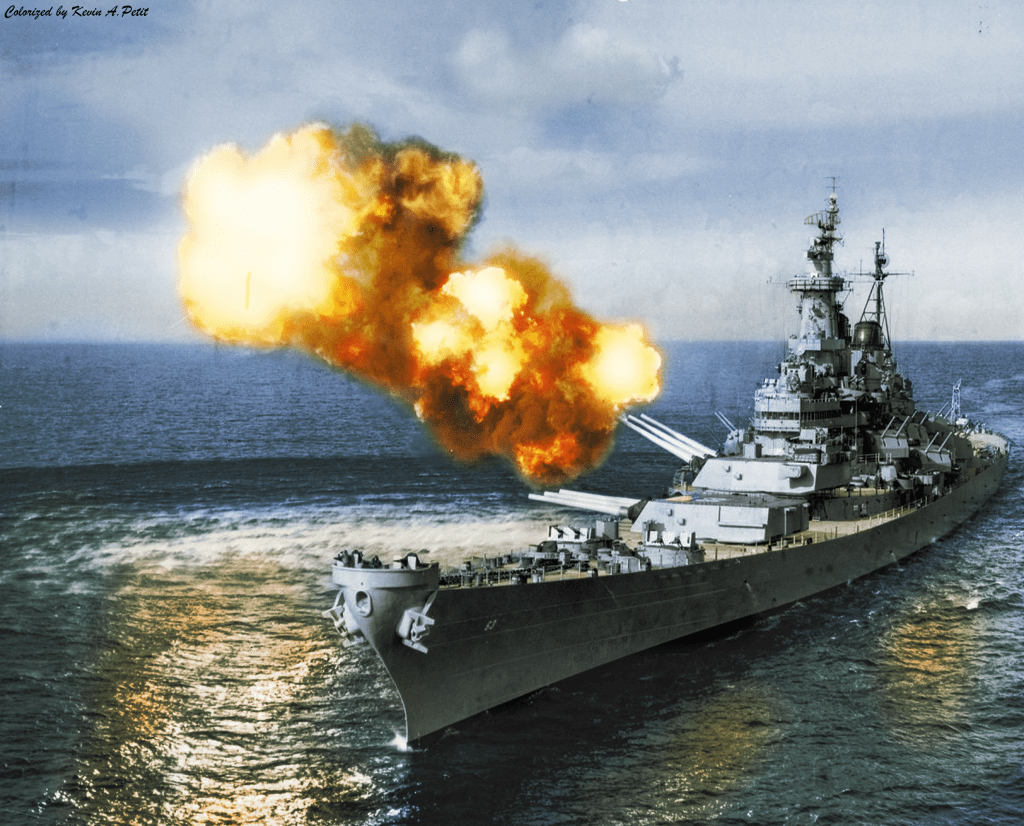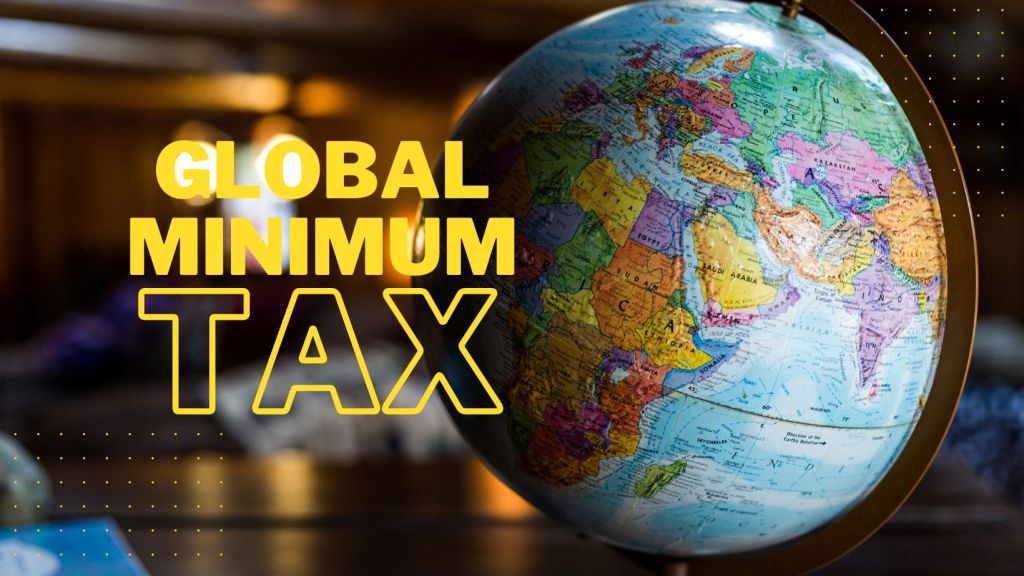Era facile intuire che il World Economic Forum 2026 sarebbe stato un momento importante e delicato, già prima che Børge Brende, il presidente di questo vertice economico che si tiene ogni anno a Davos, parlasse dell’attuale contesto geopolitico definendolo “il più complesso dal 1945 a oggi”. Difficile dargli torto: il club dei big dell’economia occidentale, che volta per volta ha ospitato i presidenti di Paesi del Sud globale considerati più vicini, si è trovato ad affrontare le profonde contraddizioni che si sono aperte al suo interno, tra guerre commerciali, azioni di forza condotte fuori dal diritto internazionale, minacce e insulti tra gli stessi membri del G7. Proprio nelle stesse ore in cui si apriva il WEF, tra Stati Uniti ed Europa scoppiava l’ennesima guerra dei dazi, stavolta per una questione geopolitica, il controllo della Groenlandia.
Il ciclone Trump si è presentato con la più grande delegazione statunitense di tutti i tempi, oltre al presidente ben cinque ministri; con un discorso incendiario ha sottolineato le sue mirabolanti azioni a favore della pace e i grandi risultati ottenuti in campo economico – per ora solo fantasie che nemmeno nel suo Paese, visti i sondaggi, riescono ad attecchire. La delegazione cinese si è invece presentata sottotono, presieduta dal vice-primo ministro He Lifeng. E ancora una volta la potenza asiatica si è caratterizzata per la sua volontà di rilanciare il multilateralismo, invitando al dialogo e opponendosi alle forzature, che siano dazi o azioni militari.
A Davos si è fatto lo sforzo di affrontare temi geopolitici quando, invece, il forum è nato per discutere di economia. Inevitabilmente sono emerse le distanze tra il mondo della finanza e dell’industria multinazionale, di ispirazione globale, e quello di Donald Trump, fatto di dazi e del ricorso disinvolto alla forza per imporre un ordine che, secondo le stesse parole del presidente, dovrebbe beneficiare fondamentalmente solo gli Stati Uniti. Il WEF è entrato così nella schiera degli ambiti di discussione e di conciliazione tra le potenze che una volta si identificavano con il concetto di Occidente, come il G7 e il WTO, organismi ormai in via di archiviazione.
Non solo il G20, ma i vertici dei Paesi Brics offrono spunti più interessanti e di più ampio respiro in un mondo nel quale regna il “si salvi chi può”, ma dove ancora si registrano anche importanti tentativi di creare alleanze multilaterali: come l’accordo tra la UE e il Mercosur o quelli che riguardano la nuova Via della Seta. Gli Stati Uniti, che potrebbero essere protagonisti del dialogo multilaterale facendo valere il loro peso, hanno invece scelto di fare da sé. Con la conseguenza di un crescente isolamento e, fin qui, senza che queste politiche abbiano generato ricadute positive sui cittadini statunitensi ai quali, due anni fa, era stata promessa una nuova era dell’oro.