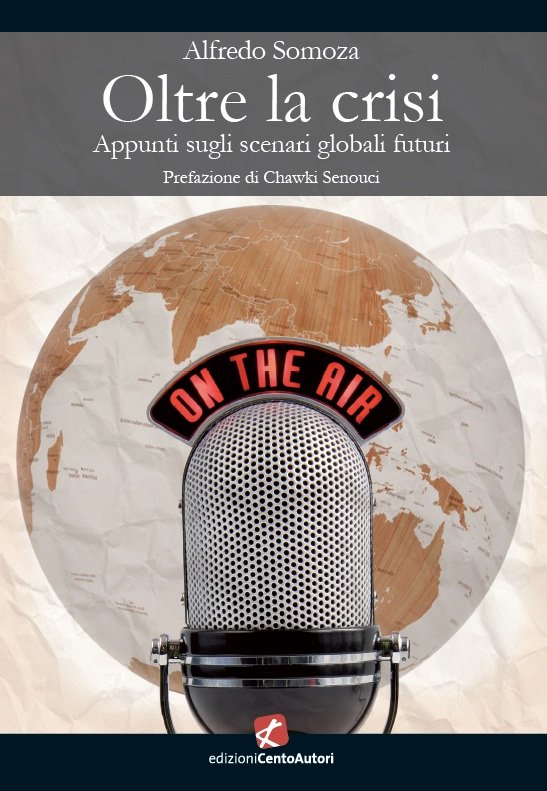I grandi volani della globalizzazione degli anni ’90 sono state da un lato le certezze giuridiche sui capitali investiti all’estero e la possibilità di rimpatriare i profitti, dall’altro le legislazioni ambientali inesistenti o troppo permissive dei Paesi che attiravano investimenti e, soprattutto, il costo del lavoro. Dalle maquiladoras del Messico ai giganteschi impianti di assemblaggio di Shanghai, le imprese per vent’anni hanno portato la produzione dove c’erano le migliori opportunità in materia salariale e poche grane sindacali.
Le storie di sfruttamento minorile e femminile, le condizioni inumane delle catene di montaggio malesi o cinesi hanno scandito la cronaca degli ultimi vent’anni. Oggi però la situazione sta velocemente cambiando. L’equazione “produco e vendo dove mi conviene”, quasi sempre in Paesi diversi, pare reggere sempre di mano. E ciò perché nei Paesi emergenti i salari sono aumentati e il costo dei trasporti e della logistica pure; perché i sindacati sono nati o sono riusciti a entrare dove prima era vietato; perché ormai tutti si stanno dotando di una legislazione ambientale.
Il vero motore del cambiamento passa però da un’altra grande “scoperta” del turbo-capitalismo contemporaneo: se gli operai perdono il lavoro perché è stata portata via la fabbrica, prima o poi escono dal mercato consumatore. Se una società “ricca” si impoverisce, i prodotti di alta fascia, anche se costruiti a basso costo, non li compra più nessuno. Non basta dire che, nel frattempo, nei Paesi emergenti sono entrati nel mercato consumatore centinaia di milioni di nuovi impiegati e operai strappati all’agricoltura, perché per quel mercato si produce in loco.
A questo punto la logica alla base della globalizzazione anni ’90 viene meno. Non si parla più di un mercato globale, ma di un mercato segmentato e servito da una produzione sempre più “nazionale”. Un esempio è il nuovo modello di iPod in plastica, destinato al mercato orientale a un prezzo dimezzato rispetto all’originale in alluminio. Gli Stati Uniti, patria delle aziende che per prime hanno delocalizzato, sono oggi invece la capitale del backshoring, tecnicamente il ritorno in patria delle imprese che se ne erano andate.
E questo non solo per la minore convenienza a produrre all’estero, ma anche perché il governo Obama e alcuni Stati particolarmente colpiti dalle delocalizzazioni, come la California, hanno cominciato sia ad aumentare la pressione fiscale sui prodotti manufatti all’estero sia a offrire incentivi e facilitazioni alle imprese che reinvestono sul suolo americano. La California ha incentivato l’industria creando 350.000 nuovi posti di lavoro nel 2012. Obama ha più volte minacciato di colpire fiscalmente le aziende americane che non abbiano nei loro piani di investire negli USA e, come nel caso della Chrysler , è intervenuto finanziariamente per impedire il trasloco del marchio all’estero.
Queste nuove caratteristiche della globalizzazione offrono maggiori possibilità di competere alle imprese di dimensioni nazionali, ma soprattutto permettono il consolidamento di tante lotte per i diritti dei lavoratori sacrificate in questi anni sull’altare dei costi “stracciati”. In Europa come in Asia, il costo sociale dell’arricchimento di chi vendeva a 100 euro in Occidente un paio di scarpe costato 5 in Oriente non è più sostenibile. La globalizzazione può davvero diventare una grande opportunità: soprattutto se perderà del tutto le caratteristiche che si sintetizzano nell’aggettivo “selvaggia”.
Alfredo Somoza per Esteri (Popolare Network)