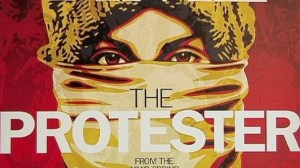Il 2012 si apre sotto i peggiori auspici. Le notizie dall’Europa e dagli Stati Uniti confermano che si tratterà, se va bene, di un anno di recessione per l’Occidente e di rallentamento della crescita per i Paesi emergenti. Se invece va male, il fallimento dell’euro porterà a una serie di default di Stati nazionali con pesanti conseguenze per il progetto di unificazione continentale.
Un’Europa ulteriormente divisa e indebolita, proprio mentre gli Stati Uniti provano a gestire la fine del loro ruolo di potenza mondiale, determinerebbe sicuramente l’aggravarsi dei conflitti in corso e favorirebbe l’insorgere di nuovi scontri dettati da ragioni economiche e geopolitiche. Si delineerebbe un orizzonte di dissoluzione dello scenario internazionale, con il ritorno ai protezionismi e alle autarchie, in un contesto nel quale la democrazia diventerebbe un optional e i diritti umani una variabile secondaria.
Eppure c’era da aspettarsi che la fine del predominio economico secolare delle nazioni occidentali avrebbe prodotto gravi scompensi. È il conto salato che ci lascia in eredità il ventennio liberista: un periodo durante il quale si è pensato di fare a meno della politica per governare i conflitti, per sedare gli estremismi, per ripianare le disuguaglianze. Le stesse medicine che si sono somministrate per decenni ai Paesi periferici vengono ora riproposte ai grandi Stati, e i media scoprono quanto siano amare e soprattutto pericolose.
Debito, deficit pubblico, interessi, default, disoccupazione, precarietà: fino a 10 anni fa erano concetti e parametri utilizzati per l’analisi dei Paesi del Sud del mondo, mentre oggi diventano l’incubo di Spagna, Italia, Stati Uniti, Francia. Troppo grandi per fallire, si dice di questi Paesi. Ma ne siamo sicuri?
I ritardi nello sviluppare un pensiero economico alternativo ai dogmi degli anni Novanta sono notevoli. Nazionalizzare l’economia è oggi fuori discussione e i pochi palliativi che si possono mettere in campo, come la Tobin Tax, trovano più ostacoli che sostenitori.
Dalla crisi dei subprime in poi, nulla di nuovo è stato fatto se non trasferire quote miliardarie di capitali pubblici verso il settore bancario, aumentando il debito che i cittadini, magari precari o disoccupati, dovranno onorare. È come se non ci fosse una via di uscita allo schema tradizionale dell’economia di mercato che considera come unica molla dello sviluppo la crescita infinita della produzione e del consumo di beni. I cittadini assistono in silenzio, per ora, alle conseguenze delle decisioni prese in luoghi senza legittimità democratica.
È un meccanismo inceppato, quello della crescita infinita: l’unica riflessione possibile deve svilupparsi attorno al concetto di decrescita, cioè di ripensamento del modello produttivo e dei consumi. Esiste infatti un sistema di pensiero che teorizza una ridistribuzione delle risorse in base ai bisogni reali e non a quelli indotti, considera la socializzazione e la partecipazione come risorse strategiche, prende in considerazione il riciclo e riutilizzo dei beni manufatti e la transizione energetica. Un pensiero che in questa crisi ogni tanto affiora, ma alla fine non viene mai presso in considerazione dagli economisti “seri”: quegli stessi che non solo non hanno previsto il rischio di default, ma non hanno neppure la minima idea di come uscirne.
Oggi l’unica rivoluzione possibile è quella del coraggio. Il coraggio di fare e non più di subire; di uscire dai dogmi ideologici in materia economica e di incentivare e sostenere la sperimentazione di nuovi modelli di consumo e produzione. Se il mondo troverà questo coraggio, il 2012 potrebbe essere l’anno della svolta. Se invece continuerà la navigazione a vista, forse la profezia dei Maya si avvererà, non perché il pianeta sarà distrutto da un gigantesco meteorite, ma perché finirà il mondo che abbiamo conosciuto finora.