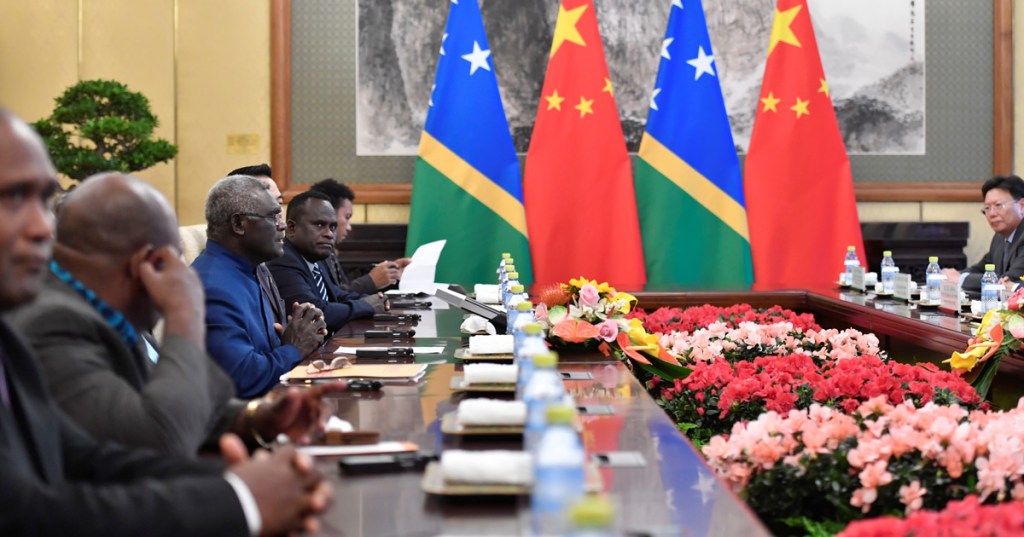Ma sarà finito sul serio il tempo dell’abbondanza, come ha recentemente dichiarato Emmanuel Macron? E di quale abbondanza parlava? Soprattutto, abbondanza per chi? I leader occidentali ovviamente parlano pensando al proprio elettorato, ma le loro dichiarazioni riscontrano un’eco mondiale data l’“importanza” dei rispettivi Paesi. È un riflesso condizionato della grande stampa nato ai tempi degli imperi coloniali, quando la parola della regina Victoria risuonava dall’India al Canada, e confermato poi dal ruolo assunto dalle grandi potenze, come gli Stati Uniti, dove il presidente di turno ha poteri di indirizzo sull’andamento del mondo.
La cosiddetta abbondanza cui si riferisce Macron è proprio il lascito di questa storia. Un’abbondanza che finora ha coinvolto meno di un miliardo di persone su un totale di otto miliardi di abitanti del pianeta, dovuta in buona parte al differenziale tra il valore delle merci vendute e il prezzo pagato ai produttori delle materie prime: soprattutto quando quel prezzo, e cioè nella maggior parte dei casi, veniva fatto dal compratore e non dal venditore. I rapporti economici coloniali e neocoloniali hanno permesso l’accumulo di ricchezze diventate poi possibilità di consumo diffuse e, infine, risorse di welfare per i più deboli, nelle metropoli della globalizzazione dal XVI secolo a oggi. I manufatti venivano venduti a caro prezzo da chi aveva sì investito sulla filiera industriale, ma procurandosi le materie prime attraverso il lavoro degli schiavi e la sottrazione di terre, frutto delle conquiste coloniali, e successivamente acquistandole a basso costo in “virtù” del proprio peso politico e militare.
È questa la storia dell’abbondanza che ha toccato, nel migliore dei casi, un abitante della Terra su otto. Quella che nella narrazione odierna sta finendo, e dunque anche chi ne ha sentito soltanto parlare e non ne ha mai usufruito dovrebbe essere preoccupato. Il sentimento del mondo infatti è tarato su quello dei Paesi centrali, che si illudono che il loro sia un sentimento globale. In realtà le cose non stanno così: la dimostrazione più recente è la relativa indifferenza di tutto il mondo, a esclusione dell’Occidente, nei confronti della guerra in Ucraina.
L’OCSE e il FMI parlano di recessione in arrivo e quindi di bisogno di austerità. Di fatto, lo dicono a quell’ottavo della popolazione mondiale che dovrà abbassare la temperatura del riscaldamento, rimandare l’acquisto dell’auto, tagliare le spese non prioritarie. E per gli altri sette ottavi? Se le cose peggioreranno, ciò accadrà partendo dall’attuale povertà. Le conseguenze della recessione su persone di Paesi diversi saranno dunque fortemente asimmetriche: una minoranza dovrà decidere se andare o meno al ristorante, mentre una maggioranza dovrà fare salti mortali, se ci riesce, per continuare a procurarsi un pasto. Eppure la narrazione vuole che i problemi di chi, per quanto povero, ha assistenza medica gratuita, scuola pubblica per i figli, assegni di disoccupazione e pensioni sociali siano i problemi di tutti: anche di coloro che non hanno nulla. Perfino nella crisi e nella recessione, il mondo continua a dividersi tra chi ha le risorse per tamponare gli effetti sociali peggiori e chi non ne ha. La maggioranza degli esseri umani è in questa situazione, ma noi parliamo d’altro. Ecco perché non c’è da stupirsi quando le nostre preoccupazioni sulle conseguenze della guerra non sono condivise dal resto del mondo. Si tratta semplicemente di reciprocità non voluta, perché altrove c’è ben altro di cui preoccuparsi.