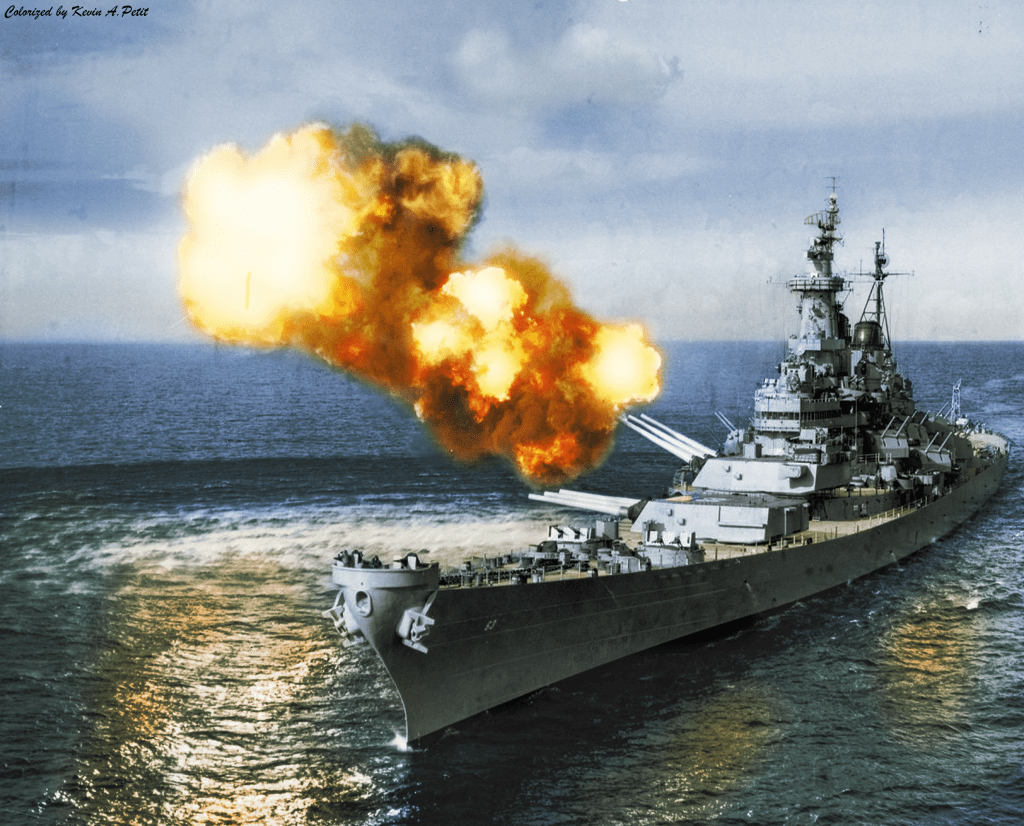La musica ci accompagna in tutte le fasi della vita, e fin dalla notte dei tempi accompagna l’umanità nel suo percorso sulla Terra. Musica che è ritmo, melodia e anche poesia, o meglio, lirica. Nella visione ottocentesca, tutte le espressioni della cultura erano classificate sulla base di uno sguardo colonialista. La “nostra” era musica, quella proveniente dall’Africa era ritmo, così come quella europea era vera arte mentre quella di altri popoli solo artigianato; lo stesso per la distinzione tra lingue e dialetti. I Grammy Awards, considerati i “premi Oscar” della musica, fin dal 1959, anno della loro istituzione, sono sempre stati improntati a questa visione. I Grammy che premiano la migliore canzone e il miglior interprete sono sempre stati attribuiti a chi canta in inglese; dal 2000 si sono aggiunti i Latin Grammy Awards, pensati per l’altra quota importante del mercato statunitense, quella che parla spagnolo. Serie A e serie B, insomma.
Nel 2025 questa divisione è stata superata: l’album Debí Tirar Más Fotos, del portoricano Bad Bunny, è stato premiato come disco dell’anno non solo con il Latin ma anche con il Grammy Award “originale”. Finalmente un riconoscimento artistico che va oltre le etichette e la lingua utilizzata (in questo caso lo spagnolo di Porto Rico), che premia l’azzardata ma vincente operazione condotta da Bad Bunny per trasformate il reggaeton, il genere cresciuto nei Caraibi ormai più di trent’anni fa, da musica dai contenuti spesso violenti e sessisti in canzone impegnata. Ovviamente senza perdere i propri fondamentali ritmici, anzi, arricchendoli guardando alla trap e “ripescando” la salsa, genere che a sua volta nacque tra gli immigrati caraibici a New York negli anni ’70 del secolo scorso. Proprio come accadde con la salsa, che con Rubén Blades cominciò a raccontare i problemi degli immigrati e a denunciare le violenze in America Latina, oggi Bad Bunny si schiera contro l’ICE, la polizia delle frontiere diventata milizia del movimento MAGA, e parla ai migranti. Una scelta che ha già avuto conseguenze: subendo un danno economico, il cantante ha cancellato le date della sua tournée negli USA per evitare di mettere a rischio i suoi fan.
La musica di Bad Bunny non è lastimosa, non cerca compassione, ma rivendica la forza e il valore della cultura latina. Nel 2024 il suo ultimo album è stato quello più ascoltato su Spotify, e Bad Bunny, che come tutti i portoricani ha il passaporto degli Stati Uniti, animerà l’intervallo del Super Bowl dell’8 febbraio in California. È questa la forza della musica che sa interpretare i tempi: nel momento in cui le persone con tratti somatici latino-americani sono sotto assedio a causa delle politiche repressive fuori controllo volute da Donald Trump, nello spazio più importante per la televisione e per l’immaginario statunitensi andrà in scena la celebrazione della loro cultura. Una beffa per Trump, che non solo perseguita l’immigrazione con metodi che vanno oltre quelli polizieschi, ma insulta e umilia le origini, i Paesi e i costumi delle diverse comunità immigrate negli USA, dai centro-americani ai somali. Mentre una certa politica si sforza di tornare indietro, di recuperare un tempo che in realtà non è mai esistito, la società continua ad andare avanti e l’arte, come sempre, ne esprime e rafforza il sentimento. Non resta quindi che godersi lo spettacolo: da un lato un presidente triste e sempre più solitario, dall’altro il cantante portoricano trentunenne che lo sfida a ritmo di reggaeton. Il video della performance di Bad Bunny al Super Bowl farà il giro del mondo e rimarrà in rete, contando milioni di visualizzazioni; i tweet di risentimento con cui Trump lo criticherà scompariranno nel giro di pochi minuti.