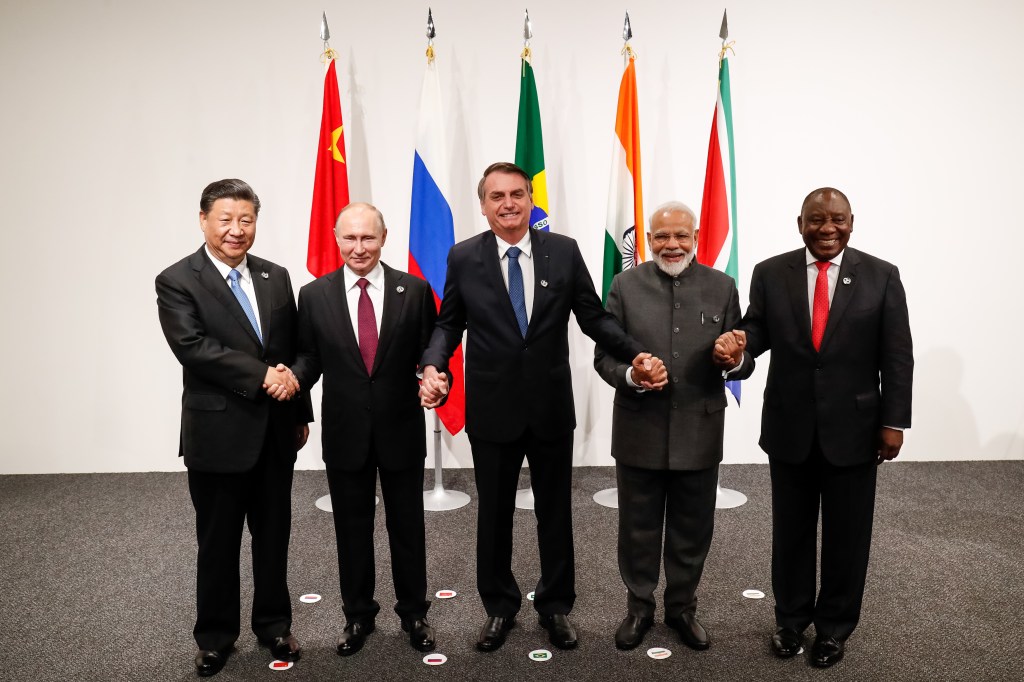La scoperta delle proprietà rinvigorenti dei frutti dell’albero di Coffea, originario dell’antica provincia etiopica di Kefa, viene attribuita a un pastore che osservò come le sue capre fossero più vispe dopo avere mangiato da quell’albero. Furono poi gli Arabi, che cominciarono a coltivarlo nella Penisola arabica, a farci conoscere fin dal Medioevo le proprietà del caffè in infusione. Questo prodotto, raro e costosissimo, conosce una svolta con il colonialismo, quando si scopre la possibilità di coltivarlo in quasi tutti i climi tropicali e subtropicali. La varietà arabica, più leggera come sapore e più povera di caffeina, viene impiantata in Centro e Sud America, mentre quella robusta, dal sapore più forte, viene esportata in Oriente. Dal XVII secolo in poi il caffè entra a far parte della trilogia dei cosiddetti “coloniali”, al vertice del commercio mondiale insieme allo zucchero e al cacao. Il consumo di caffè, e di questi altri prodotti, diventa di massa, si afferma tra i primi consumi globali e vive una continua crescita.
Storicamente il caffè detiene un primato tra le materie prime agricole provenienti da Paesi in via di sviluppo, posizionandosi dietro solo al petrolio per il valore generato: oggi 11,5 miliardi di dollari USA all’anno. Sono oltre 10 milioni le tonnellate di caffè prodotte, equivalenti a oltre 400 miliardi di tazzine, da 125 milioni di persone di 75 diversi Paesi.
Due sono i mercati dove si decide il valore del caffè: New York per la varietà arabica e Londra per la robusta. Ci sono caffè low cost, ad esempio quelli vietnamiti, caffè di qualità altissima come quello delle Blue Mountains giamaicane, caffè “bio” e tanto caffè equo e solidale, cioè prodotto usando criteri di equità nei confronti dei contadini che lo coltivano. Insomma, c’è un mondo intero dietro quella tazzina che è uno degli elementi culturali unificanti a livello globale, se è vero che in Cina, storicamente Paese del tè, il caffè sta progressivamente conquistando le preferenze delle famiglie.
Ora il rischio maggiore che incombe su questo mercato è rappresentato dal cambiamento climatico. Che sta colpendo anzitutto il “gigante” del caffè, il Brasile, che tra gelate e siccità ha perso il 19% del raccolto ed esporterà, si stima, il 37% in meno. Anche la Colombia, secondo produttore mondiale, registra un calo del 22% della produzione. Aggiungiamo la guerra civile in Etiopia, patria storica del caffè, e la riduzione della disponibilità di varietà robusta vietnamita per via delle restrizioni legate al Covid.
Come già i problemi e i cali di produzione del grano, del mais e della carne, anche la “crisi” del caffè ci ricorda la fragilità del mercato mondiale dei consumi di massa, che dipende da pochi Paesi in grado di esportare grandi quantitativi. Paesi che sono sempre più soggetti alle conseguenze del cambiamento climatico e, quindi, alla perdita di produzione. Negli ultimi 12 mesi i prezzi dell’arabica sono balzati da 128 dollari la libbra a 244: un aumento che, sommandosi a quelli dell’energia e della logistica, lascia prevedere un costo della tazzina più caro del 50% tra pochi mesi. Lo stesso sta succedendo per il prezzo del grano e della carne, beni che non si possono certo considerare voluttuari ma di sopravvivenza. La sicurezza alimentare del pianeta è sempre più a rischio perché il cambiamento climatico, oltre a colpire a turno i pochi grandi esportatori di derrate alimentari, riduce ovunque la capacità di autoproduzione.
Il consumo del caffè è anche cultura, e in diverse culture se ne “leggono” i fondi per indovinare il futuro. Oggi però non serve la caffeomanzia per sapere che l’aumento di qualche decimo di euro della tazzina non è soltanto una seccatura, ma ci racconta che il mondo sta andando verso un futuro complesso.