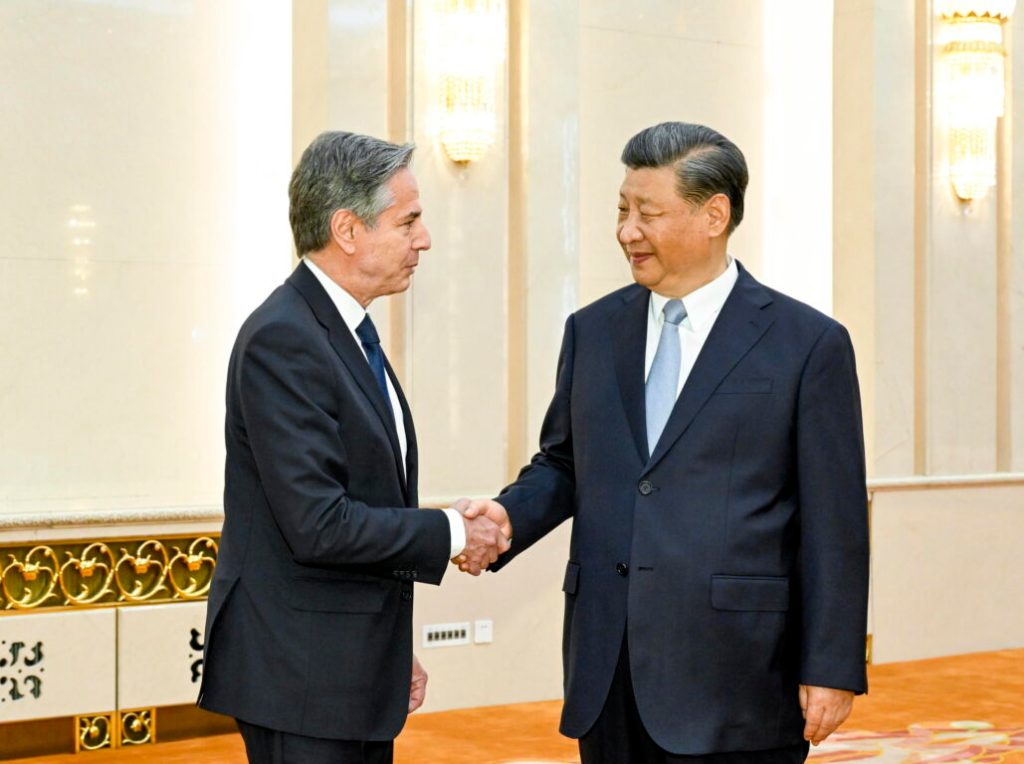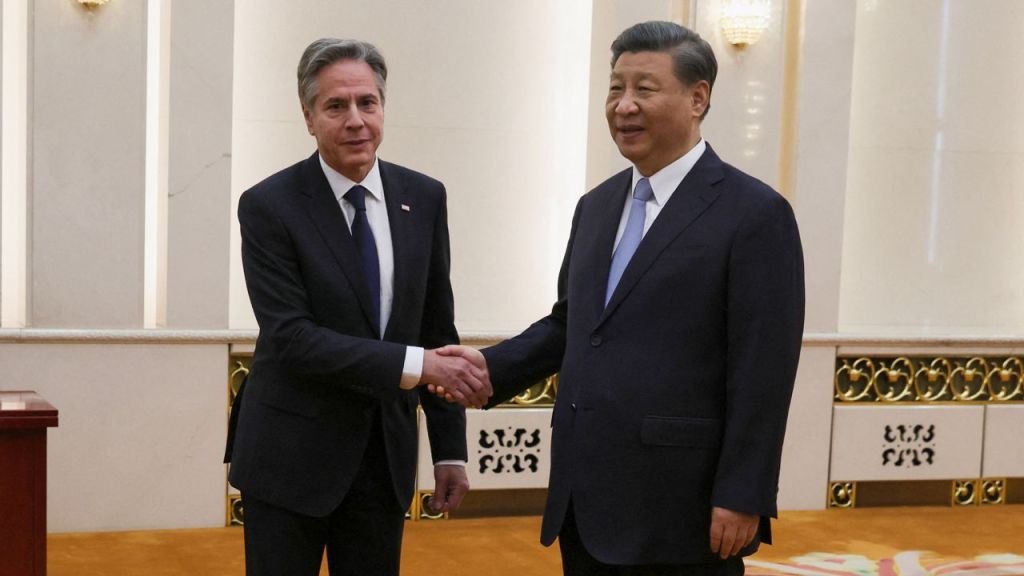La presenza di Joe Biden a un picchetto di scioperanti dell’industria automobilistica del Michigan non rappresenta solo una “prima volta” per un presidente degli Stati Uniti, ma anche una sterzata epocale per i progressisti nel mondo. Con un gesto che ha sorpreso gli osservatori, Biden ha riportato il Partito Democratico ai valori di un tempo, quando era chiaro quale settore della società rappresentasse e quale fosse la sua visione della società e dell’economia. Dopo decenni di allineamento con le idee scaturite dalla famosa “terza via” di Tony Blair e Bill Clinton, e cioè assecondare le richieste di minore tassazione e di contenimento salariale avanzate dai grandi gruppi economici, Biden prende atto delle enormi distanze sociali che si sono create a causa di un mercato deregolamentato, nel quale l’accumulo di ricchezza è avvenuto solo per i ceti più alti. Da un lato imprese che hanno registrato profitti record, amministratori delegati che negli ultimi 5 anni hanno visto aumentare i loro stipendi del 40%, e dall’altro operai sempre più poveri, con salari congelati e vittime dell’inflazione, che sta spingendo una vasta parte del ceto medio verso la povertà.
È la seconda ondata delle conseguenze della globalizzazione, che in un primo momento ha spostato posti di lavoro dall’Occidente all’Oriente in cerca di un minore costo del lavoro. Ora che le delocalizzazioni si sono fermate, si scopre che in Occidente non solo i lavoratori dell’industria sono notevolmente diminuiti, ma anche che quelli che hanno mantenuto un posto di lavoro sono scivolati nella povertà. La categoria dei lavoratori poveri, cioè le persone che non riescono a soddisfare i propri bisogni elementari malgrado abbiano un impiego, è apparsa per la prima volta in Occidente proprio negli Stati Uniti. Si trattava, in principio, di uomini e donne che svolgevano lavori non qualificati nella filiera dei servizi. Oggi però l’impoverimento è generalizzato. È come se si fosse rotto il patto sociale risalente al secondo dopoguerra, fondato su salari degni e un welfare di qualità. Questi ultimi anni hanno visto, invece, un veloce deterioramento sia dei servizi offerti dallo Stato sia dei salari, e non perché l’economia vada generalmente male. Semplicemente, l’accumulo di risorse al vertice della scala sociale è aumentato. La domanda che si sono posti gli scioperanti negli Stati Uniti è: per chi fabbrichiamo automobili, se noi stessi non possiamo più permettercele? Non è una domanda da poco, perché l’industrializzazione di massa dell’Occidente si sviluppò insieme al progressivo aumento del potere d’acquisto dei lavoratori. Lo stesso fenomeno si è verificato molto più recentemente in Cina, dove fin d’ora si pone la stessa questione. Se la crescita rallenta, la capacità di consumo interna ne soffre, e con essa interi comparti industriali dedicati a soddisfare le richieste dei ceti economicamente emergenti.
Questa situazione era stata letta finora solo con la lente del populismo di destra, che la attribuisce non alla grande sperequazione tra i ceti sociali e al mercato del lavoro, ma alla concorrenza di altri Paesi o degli immigrati. Donald Trump fece la sua fortuna elettorale nel 2016 dicendo di rappresentare i “bianchi impoveriti”, cioè il mondo operario colpito dalle delocalizzazioni. Oggi però è in imbarazzo perché lo sciopero del settore automobilistico porta alla luce problemi, come la concentrazione dei guadagni in poche mani, che un miliardario difficilmente riconoscerà. D’altra parte, Biden e i democratici dovranno fare molto di più di presenziare ai picchetti degli scioperanti. Andrebbero ridiscussi il salario minimo, le tutele, la tassazione dei profitti, gli investimenti industriali e sociali delle grandi multinazionali. Sicuramente, l’immagine del presidente democratico degli Stati Uniti col megafono in mano di fronte ai cancelli di una fabbrica entrerà nei libri di storia, perché segna un prima e un dopo nei processi di cambiamento che sta vivendo il mondo, in eterna transizione dalla fine della Guerra Fredda.