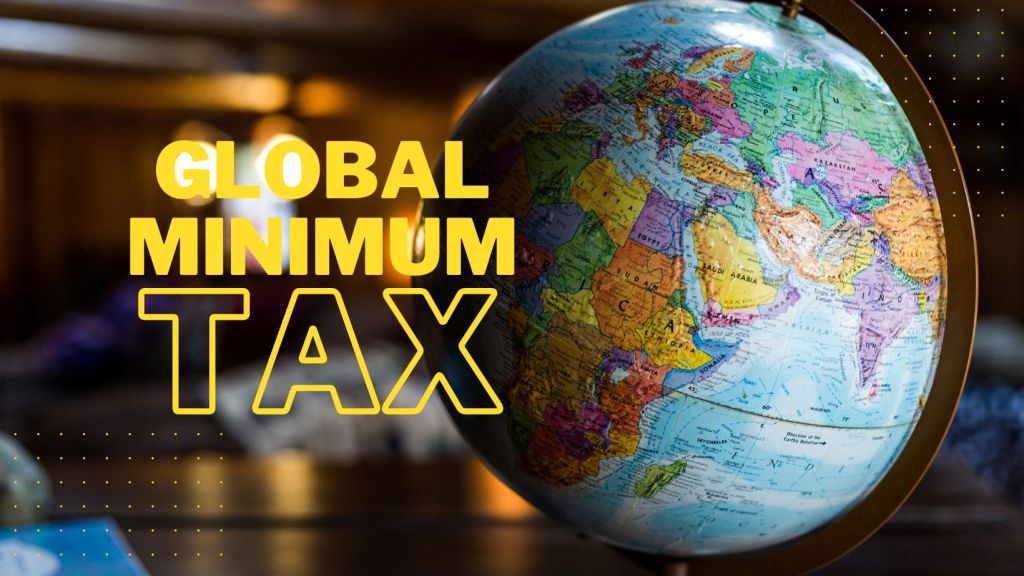L’accordo per l’istituzione della global minimum tax – l’imposta minima globale del 15% sui profitti delle multinazionali – è figlio di uno dei tentativi più ambiziosi compiuti negli ultimi decenni per riequilibrare la fiscalità internazionale. Nato nell’alveo dell’OCSE e sostenuto con forza dall’amministrazione statunitense, il progetto punta a contrastare l’elusione fiscale e la corsa al ribasso delle aliquote fiscali che da anni caratterizza la competizione tra Stati. Eppure, mentre gli occhi del mondo sono puntati sugli effetti attesi in termini di gettito e giustizia fiscale, in Europa cresce la preoccupazione che la global tax possa trasformarsi in un boomerang. A prima vista, il Vecchio Continente, e l’Unione Europea in particolare, sembrerebbero avere tutto da guadagnare: molti Paesi membri registrano da tempo perdite fiscali significative a causa del trasferimento artificiale dei profitti verso giurisdizioni più favorevoli, spesso interne alla stessa UE. L’armonizzazione minima, quindi, appare una risposta logica. Tuttavia, la dinamica competitiva tra i Paesi UE e il diverso peso delle economie nazionali rischiano di creare un quadro meno favorevole del previsto.
Il primo nodo critico riguarda gli Stati che negli anni hanno costruito parte della propria attrattività economica su un regime fiscale di vantaggio. Irlanda, Paesi Bassi e Lussemburgo hanno espresso più volte le loro riserve, temendo un indebolimento del proprio modello di sviluppo. Ma la vera incognita non è solo la resistenza politica: è l’effetto complessivo sull’ecosistema europeo. Se il vantaggio comparato di queste economie venisse meno, l’Europa non guadagnerebbe automaticamente maggiore competitività a livello globale. Anzi, rischierebbe di vedere investimenti importanti spostarsi verso regioni extraeuropee, dove l’innalzamento al 15% è percepito come trascurabile data la presenza di altre condizioni favorevoli, come il basso costo del lavoro o varie forme di deregulation.
Un secondo elemento di fragilità riguarda il ruolo degli Stati Uniti. Washington ha sostenuto l’accordo, ma l’iter di approvazione interna procede a fasi alterne, condizionato dalle tensioni tra Congresso e Casa Bianca. Il rischio è che l’UE applichi pienamente la global tax mentre altre grandi economie restano attardate, generando un’asimmetria normativa. Per le multinazionali con base americana o asiatica, l’Europa potrebbe così diventare un’area fiscalmente più onerosa, con la probabile conseguenza di scoraggiare nuovi insediamenti produttivi.
Sul fronte interno, l’UE si trova a fare i conti con la propria struttura decisionale. La fiscalità resta materia di competenza nazionale e vige il principio di unanimità: ciò ha portato a compromessi che rischiano di indebolire l’impatto della riforma. In alcuni casi, gli Stati membri stanno cercando di compensare l’aumento dell’aliquota minima attraverso altri strumenti di vantaggio, come incentivi settoriali o agevolazioni su ricerca e sviluppo. La conseguenza potrebbe essere una nuova forma di competizione interna, più opaca e meno controllabile.
Non va poi sottovalutato l’effetto sui colossi digitali, che rappresentano uno dei principali target della global tax. Molte big tech hanno costruito la loro presenza europea attraverso strutture che passano per Paesi a fiscalità più bassa. Con l’introduzione dell’aliquota minima globale, alcuni di questi gruppi potrebbero riconsiderare l’organizzazione delle proprie filiali o ridurre gli investimenti nei Paesi comunitari, privilegiando mercati più dinamici e con una popolazione più giovane.
Infine, c’è la questione del tempismo. In un momento segnato da forti tensioni geopolitiche, l’Europa sta attraversando una fase di rallentamento economico e aumento dei costi energetici, e ha difficoltà nel mantenere la propria competitività industriale. In questo contesto, qualsiasi intervento che possa essere percepito come un aggravio fiscale rischia di amplificare l’incertezza. Senza una strategia comune di attrazione degli investimenti, la global tax potrebbe accentuare le divisioni interne anziché ridurle.
L’obiettivo dichiarato della riforma resta condivisibile: garantire che le multinazionali contribuiscano in modo equo ai bilanci pubblici. Ma l’UE, pur essendo tra le regioni più impegnate nella lotta all’elusione, non può ignorare il rischio di diventare l’area dove il nuovo sistema produce gli effetti più rigidi. La sfida resta quella di trasformare la global tax in un’opportunità di riequilibrio, evitando che i principi di giustizia fiscale si traducano in un ulteriore freno alla competitività del continente.